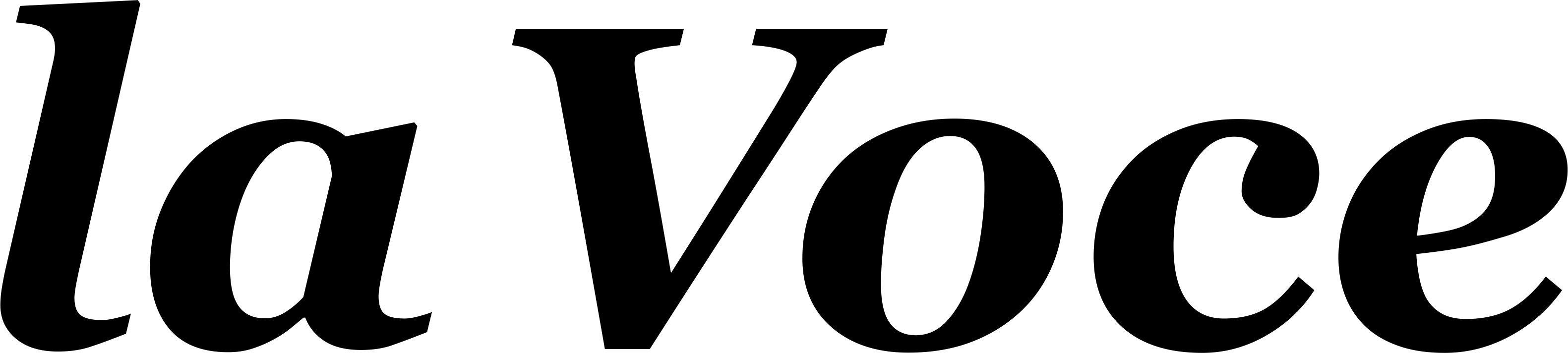Sabato scorso, nella Chiesa Madonna di Loreto delle Due Casette, si è svolto un emozionante evento che, a mio parere, è andato al di là dell’evento stesso. Stiamo parlando della prima edizione del Festival Internazionale dell’AgriCultura, ideato dal Maestro Agostino De Angelis e dall’Associazione ArchéoTheatron di Desirée Arlotta. Ma non sono sicuro che tutti i presenti, soprattutto i più giovani, abbiano perfettamente compreso quello che i testimoni hanno raccontato, sia in presenza che in video. Questo non perché le testimonianze e i documenti fotografici o video non fossero storicamente significativi o addirittura teneramente commoventi, ma perché si è cercato di raccontare un mondo che non esiste più. Troppo lontano dal nostro recente quotidiano. E che, a mio parere, è difficile comprendere senza averlo vissuto personalmente. È un po’ come parlare di disabilità a chi in famiglia non ha un figlio disabile, o di guerra a chi non è mai stato in trincea. Le testimonianze e i testimoni sono stati ben scelti, e ben presentati da Agostino De Angelis. I ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Marina di Cerveteri e del Giovanni Cena hanno letto le storie dei loro nonni, catapultati nelle nostre campagne dalla riforma agraria dell’Ente Maremma, da cento paesi diversi. Ma, a mio parere, l’errore inevitabile, se così si può chiamare, è quello di chiamare “campagna” quello che gli assegnatari hanno trovato al loro arrivo. Non era la campagna come l’intendiamo noi. Bucolica, e luogo di fatiche premiate da raccolti più o meno abbondanti. Quella sarebbe arrivata dopo qualche anno. Era un Far West non diverso da quello raccontato dai film western. A parte naturalmente i Sioux. Un West alle porte di Cerveteri. Quello che avvenne nelle nostre campagne negli anni ’50, non ci fu una semplice ridistribuzione delle terre, ma una vera e propria colonizzazione. Quelle campagne, come i territori americani del West, erano prive di tutto e bisognava costruirci tutto, se ci si voleva viverci con le famiglie e lavorare la terra. I nonni raccontati dai ragazzi delle due scuole trovarono, è vero, delle accoglienti case coloniche. Erano dignitose per quei tempi: una grande cucina, tre camere e un bagno al piano superiore, la stalla per le mucche e i magazzini al piano terra. Oltre all’abitazione principale, furono costruiti un pollaio, una porcilaia, un fontanile per abbeverare gli animali e un grande forno per cuocere il pane. Ma questo era tutto: era una casa colonica costruita nel nulla, come le fattorie del West americano. Mancava l’elettricità. Di giorno c’era il sole e di notte la luce proveniva dalle candele e dalle lampade ad olio. Mancava il telefono. Mancava l’acqua corrente, almeno all’inizio. L’acqua l’andavano a prendere le donne, come in Africa, con le brocche poggiate sulla testa, al fontanile più vicino o, a I Terzi, alla fonte dell’”acqua acetosa” distante diversi km. Mia madre, ma non solo lei, ancora soffre dei postumi di questa attività quotidiana. Gliela ricordano ogni giorno i dolori provenienti dalle sue vertebre schiacciate. E i panni si lavavano nel fosso, contendendo l’acqua, gelata d’inverno, con i girini che allora erano abbondanti. Parlando de I Terzi, che conosco un po’ meglio, non c’era nessun mezzo di trasporto: nessun autobus, nessuna macchina privata se non il camioncino del proprietario del bar e della dispensa. Solo una bicicletta e qualche anno dopo, se andava bene, una Lambretta. Cerveteri era separata da I Terzi da soli 15 Km di strade, chiamiamole così, polverose d’estate e fangose d’inverno. Ma per le famiglie appena giunte da mezza Italia era lontana e irraggiungibile quanto la Luna. L’isolamento in mezzo a quel nulla era praticamente completo, e pesava su di tutti. Ma in modo particolare sui giovani, che non avevano modo di incontrare i loro coetanei se non la domenica a messa. Una vita difficile, iniziata con un trasferimento dal loro paese d’origine, non su dei carri come per i coloni americani che andavano ad occupare le selvagge terre del West, ma su un vecchio camion. Portavano poche cose con loro: i materassi, i pochi abiti, quello che rimaneva del corredo della madre e quello che si stava mettendo da parte per le figlie più grandi. Il pentolone di rame per cuocere la pasta e poco più. Si partiva poveri dal paese natio, e si arriva ancora più poveri in quel nulla dove mancava tutto. Solo il futuro diventava meno nero a mano a mano che il camion si avvicinava alle terre loro assegnate. Li c’era la terra da coltivare, e con essa si poteva dire addio alla cronica mancanza di lavoro in quell’Italia del primissimo dopoguerra. “… La terra è bassa…” diceva sempre mio nonno, ma con quei dieci ettari circa che venivano assegnati ad ogni famiglia, finalmente ci si doveva piegare solo per zappare l’orto, e non era più necessario chinare la schiena davanti a chi sfruttava il lavoro degli altri.