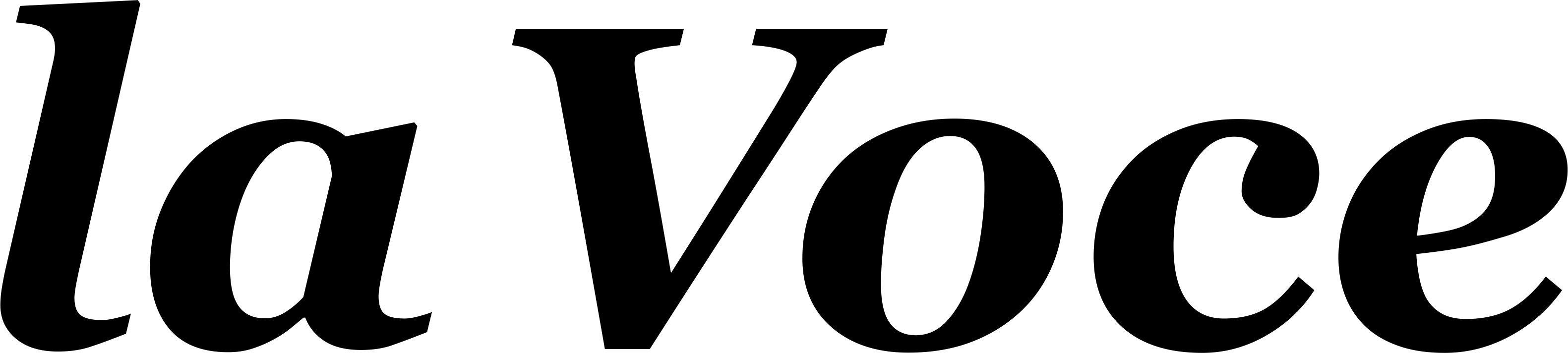di Angelo Alfani
Prima ,molto tempo prima che diventasse “il paese dello sconforto”, Cerveteri era meta ambita di umani che vi si trasferivano dal nord della nostra lunga e stretta penisola. Da Mantua la bella, dalle sabbiose terre ferraresi fino alle paludose piane venete, dalla Gorizia irredenta e “maledetta” ,decine di uomini vi scesero a cercare fortuna. Prima ,molto tempo prima che ad un qualche avveduto cittadino venisse in testa di consigliare agli Amministratori della cosa pubblica di trascorrere un weekend in ritiro, “per fare spogliatoio”, dai frati cappuccini a Bracciano, un bresciano seccosecco ,occhi allampanati, passo lungo alla Don Camillo, s’arrampicò su per i giardini fono ai sampietrini, nel cuore del paese arioso. Il suo nome era Giuberti Dante Giuseppe , stagnino provetto. Ospite da ascriversi nel novero degli illustri che ha lasciato ricordi indelebili tra i cervetrani, suoi compaesani per scelta. Nato a Verolanuova il 24/10/1895, figlio di Achille e di Penocchio Rosa, emigrato nel comune di Manerbio il 21/04/1922, trasferitosi a Cerveteri nell’agosto del quaranta, deceduto in Roma il 13/04/1967.Così recitano le informazioni dell’anagrafe. Consultate le liste di leva della classe 1895 è risultato che Dante venne ritenuto inabile sia nel 1914 che nel 1915 per costituzione debole. Nel 1916 venne dichiarato abile di prima categoria: la Patria,”asservita” a sanguinari politici e generali,aveva bisogno di carne da macello per cui, anche un manifestamente “inabile”, andava bene.È storia che anche i manicomi vennero svuotati. Si racconta che arrivasse a Cerveteri in un pomeriggio in cui il cielo era nero, nero pece, rotto ogni tanto dai bagliori lividi che ingigantivano le cime orlate di lampi delle colline ombrose. Tipico temporale di fine estate di quelli che rompono improvvisamente l’incantesimo dei bagni al mare. Un cappello di alpino in testa, scarponi militari chiodati ed un sacco di juta in spalla.
Nel sacco gli “strumenti” di lavoro per riparare ogni tipo di pentolame di rame. Girando per il paese e le campagne al grido “Donne c’è lo stagnino!” le signore sbucavano fuori dai portoni consegnandogli utensili di rame da sistemare. Dante ,buttatili nel sacco, dava tempi di riconsegna precisi e puntuali. Stagnava pignatte ,callaretti, imbuti vari ,pompe dell’acqua ramata. Ultimava l’opera con parecchie smanate d’ovatta e sputo così che il rame brillasse come le lance di Achille nella piana di Troia. I primi anni della sua esistenza in terra d’Etruria li trascorse nel casaletto, dove ora insorge la merce dei pronipoti di Mao, luogo allora considerato “alli sprofonni”. Lo aveva “gonfiato” aggiungendo un prolungamento a cannucce intrecciate da fil di ferro, ai cui ganci penzolavano regolarmente lunghe pelli striate e pellame con lunghe code. Si perché il nostro stagnino, cuoco a quanto si dice a tre stelle , prediligeva la carne di frustoni e di gatti inselvatichiti . Come tutti i padani la cottura in salmì era la sua indiscutibile specialità. Nel primo periodo non erano poche le famiglie che lo invitavano a pranzo in cambio della riparazione del pentolame . Non arrivava mai a mani vuote:la sua offerta preferita erano i fichi d’india lavati e spinati stretti tra foglie di fico. Nel cinquantasei, quando i proprietari del terreno iniziarono a costruirci casa, Dante lasciò il casaletto per trasferirsi in quello che fu il suo ultimo indirizzo: Viale della Necropoli Etrusca Palazzo Sottoponte int. 1= Cerveteri . Per un lungo periodo girava per il paese e le campagne con un carretto sgangherato tirato da un somarello sardo. Si racconta che venne fermato dai militi lungo la strada che dall’Aurelia porta a Cervetri proprio in un tratto in salitella. Agli uomini in divisa che chiedevano spiegazioni sulla mancanza di stop e d altre fesserie del genere Dante, ripetendo frasi incomprensibili , si allontanò lasciando la capezza del somaro. “Teneteve tutto,puttana di quella vaca!Io mee vò !”. I militari, sbigottiti, ,col sudore che gli si appiccicava alla divisa ,lo rincorsero, urlando: “Torna indietro disgraziato!Ripiete sto somaro ,daje!Movete noi chiudemo tutte e due l’occhi, ma non te fa più vedere da sté parti!”
Raccontano che un giorno arrivò al suo indirizzo, poi si dice che le Poste non funzionano, una lettera di un suo fratello che gli proponeva di ritornarsene al nord,dalle parti della” Leonessa d’Italia”. Manco per niente: oramai si sentiva a casa sua dentro alla tomba del quarto secolo.
“ Miaoo,miaoo, miaoo” era il verso, simile a quello di un gruppo di gatti in amore, che terribili ragazzini gli rivolgevano tenendosi a debita distanza ,quasi sempre a cavalcioni sopra il muricciolo del ponte. ”Tu magna l’erba che io magno la carne, stupido! E’ più bono del conècc!” gli urlava dietro Dante. Il suo callaretto annerito dall’uso era sempre in funzione fin dalle prime ore del mattino. il fumo segnalava la presenza dello stagnino sotto al ponte. Su cervetrani che, a loro insaputa, hanno mangiato serpi o peggio ancora gatti se ne raccontano un sacco e ‘na sporta. Ad un padano come lui, lungo una quaresima, si racconta che invitato per un pranzetto d’anguille a fine pasto gli disse .”Era bona la bissia!?”. Il Titano mantovano fu visto rincorrerlo col callaro lungo la via degli Inferi. Aveva il vezzo di avere sempre in bocca, a secondo delle stagioni, un filo d’erba, un rametto di finocchina, o una fogliolina di menta selvatica ,come se si aspettasse di morire da un momento all’altro e volesse morire col sapore della natura cervetrana in bocca. Assieme a selezionati amici di sgargarozzate di vino,andava a “far compagnia” ai morti ,posteggiati nella cappella pubblica del cimitero in attesa di sistemazione. “Bisogna avere paura dei vivi mica dei morti!” rispondeva, con una nota di vago rincrescimento nella voce, a chi ne chiedeva ragioni.
Per molti anni una bastardina di nome Padella (come altro si sarebbe potuta chiamare) fu la sua ombra. Tenendo in mano un cerchione di bicicletta, privato dei raggi, lo stagnino gli sussurrava: “Salta Padella !Vai piccinina,salta!” e lei saltava da una parte all’altra dando spettacolo, che manco al circo Saltanò potevi assistere. Taciturno per lo più, quando parlava lo faceva in falsetto bresciano. Se si accorgeva che l’insistenza nel fargli domande nascondeva il desiderio di prenderlo per il sedere, si chiudeva in un silenzio da sordomuto. Alla fine, a fronte di una estenuante insistenza, sentenziava: “Io dico cinquemila parole al giorno se mi fate parlare il doppio campo un giorno in meno”. Tra le leggende che lo circondano c’era anche quella del recarsi, nei momenti di profonda depressione psicofisica, al mattatoio comunale a bersi un bicchierone di sangue di bue per ridarsi forza e sicurezza. La sua figura magra e traballante la si vedeva scendere giù per la strada che porta alle Tombe appoggiata alla bicicletta Bianchi dai freni a bacchetta. Nessuno in paese se lo ricorda in sella: era lui che portava la bicicletta. Durante le tante passeggiate malandrine a cercà fratte alla mejo gioventù capitava spesso di vedere entrambi infilati in una cunetta, lui ubriaco fradicio e la bicicletta con la ruota posteriore per aria che ancora girava.
Lo trovarono nella cunetta ,non lontano da “casa”, tra un cipresso ed un pino, la prima settimana d’Aprile. La ruota della bicicletta girava ancora mentre gli occhi di Dante cercavano di bucare l’ombrosità del cipresso a ricercar le stelle. Anche allora aveva infilato tra i denti uno striminzito sparicio. Dopo essere stato sepolto a terra le sue ossa, e ce n’aveva a chili, sono ammucchiate con altre nell’ossario comune.
P.s.: Testo e foto in copyright :vietato riprodurre se non col consenso dell’Autore